| |
 Distillati Distillati
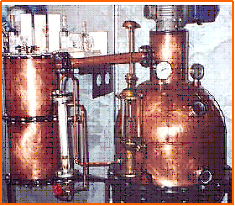
(a)lambicco=distillatore
=ACQUAVITE (EAU-DE-VIE IN FR)
Distillazione
Distillazione Operazione che consiste nel separare le varie componenti di una miscela liquida. Si attua
riscaldando il liquido fino al punto di ebollizione, in
modo che evaporino le componenti più volatili – quelle dotate di punto di ebollizione più basso – che
vengono poi recuperate per condensazione. Lo scopo
della distillazione può essere il recupero di un solvente da una soluzione in cui siano disciolte sostanze
non volatili oppure, più comunemente, il frazionamento
di una miscela complessa nelle componenti di diversa volatilità.
Operazioni per certi versi complementari alla distillazione sono l'evaporazione e l'essiccamento, impiegati
per allontanare il solvente da una soluzione allo
scopo di recuperarne il soluto. La distinzione tra i processi di distillazione e quelli di evaporazione
è però solo formale, poiché in entrambi i casi vengono
usate le medesime apparecchiature.
|
2
|
|
TEORIA DELLA DISTILLAZIONE
|
La distillazione si basa sul fatto che il vapore ottenuto per ebollizione di una miscela di più liquidi
contiene una percentuale maggiore dell'elemento più volatile
rispetto alla miscela di partenza. La relazione tra la composizione di una miscela di liquidi e la composizione
del vapore con essa in equilibrio fu ricavata dal
chimico francese François-Marie Raoult (1830-1901) ed è oggi nota con il nome dello scopritore. Secondo
la legge di Raoult, in una miscela di liquidi
perfettamente miscibili (soluzione ideale) ogni componente ha pressione di vapore pari a quella che
avrebbe se fosse puro moltiplicata per la propria frazione
molare nella soluzione. Il punto di ebollizione di una miscela ideale viene raggiunto quando la somma
delle pressioni parziali dei singoli componenti eguaglia la
pressione esterna, che in condizioni normali è pari a una atmosfera. Quindi una soluzione ideale di
due liquidi in quantità equimolare bolle a una temperatura
che è data esattamente dalla media dei punti di ebollizione delle due sostanze pure.
Il grado di separazione ottenuto con un singolo stadio di distillazione dipende esclusivamente dalla
differenza tra le pressioni di vapore dei componenti puri,
perciò, in ultima analisi, dalla differenza tra i loro punti di ebollizione. In particolare, minore
è la differenza tra i punti di ebollizione delle sostanze pure, minore
è la separazione ottenibile con un singolo stadio. Distillando una soluzione di una sostanza non volatile
(ad esempio un sale) per recuperare il solvente, è
possibile ottenere una separazione completa con un unico stadio; al contrario se la differenza tra i
punti d'ebollizione è minima, è impossibile separare i
componenti della miscela con una sola distillazione. Ad esempio, se si scalda una miscela di acqua (che
bolle a 100 °C) e di alcol (che bolle a 78,5 °C), si
ottengono vapori arricchiti in alcol, ma comunque contenenti acqua. Per ottenere una soluzione di alcol
al 50% partendo da una al 10%, è necessario
distillare ancora una o due volte i vapori raccolti nella prima distillazione; per avere una soluzione
di alcol al 95% è necessario ripetere il processo un gran
numero di volte.
La relazione di Raoult si applica correttamente solo a miscele di liquidi molto simili per struttura
chimica, come ad esempio il benzene e il toluene, mentre
nella maggior parte dei casi si osservano forti deviazioni dal comportamento ideale (soluzioni reali).
Infatti, se un componente è poco solubile negli altri della
miscela, la sua volatilità aumenta notevolmente. Ad esempio, la volatilità dell'alcol in soluzioni acquose
diluite è sensibilmente maggiore di quella che si può
prevedere applicando la legge di Raoult. Al contrario, l'ebollizione di una soluzione al 99% di alcol
determina la formazione di vapori contenenti una
percentuale minore di questo componente; come conseguenza di ciò l'alcol non può essere concentrato
tramite distillazione oltre al 97%, anche ripetendo il
processo per un numero idealmente infinito di volte.
Tecnicamente il termine alambicco si riferisce solamente al contenitore in cui si portano a ebollizione
i liquidi da distillare; nella maggior parte dei casi, però,
viene usato per indicare l'intero apparato, costituito dalla colonna di frazionamento, dal condensatore
e dal contenitore in cui viene raccolto il distillato. Gli
alambicchi utilizzati in laboratorio sono in genere di vetro, mentre quelli adibiti a impieghi industriali
sono di ferro o d'acciaio; in alcuni casi, per evitare che il
ferro contamini il prodotto di distillazione, vengono preferibilmente usati apparecchi di rame.
|
4
|
|
DISTILLAZIONE FRAZIONATA
|
La distillazione viene detta frazionata quando viene realizzata in più stadi, sottoponendo le frazioni
che si formano nelle prime fasi del processo a più
distillazioni successive.
Consideriamo nuovamente la soluzione di alcol al 10%. In un impianto di rettifica, il liquido da distillare
viene immesso alla base di una lunga colonna (detta
di rettifica o di frazionamento) dotata di una serie di piatti. Una parte del distillato, prodotto dalla
condensazione dei vapori che si formano in testa alla
colonna, viene prelevata dal condensatore e viene fatta gocciolare nuovamente nella stessa, costituendo
il cosiddetto riflusso. Il vapore che sale verso il
condensatore gorgoglierà attraverso il liquido, arricchendosi in alcol e perdendo parte dell'acqua per
condensazione. Ogni piatto della colonna di
frazionamento corrisponde quindi a uno stadio di distillazione; in questo modo, usando una colonna con
un numero sufficiente di piatti, è possibile ad
esempio ottenere alcol al 95% in un unico passaggio. Inoltre, se la soluzione iniziale di alcol viene
introdotta progressivamente circa a metà colonna, l'alcol
può essere separato dall'acqua mentre scende verso il piatto inferiore, e può essere recuperato senza
perdite.
Questo metodo, noto generalmente come rettificazione o distillazione frazionata, viene usato industrialmente
non solo per semplici miscele di due sostanze,
ma anche per soluzioni più complesse, quali ad esempio quelle presenti nella pece o nel petrolio. La
colonna di frazionamento più usata è la torre di
gorgogliamento, in cui i piatti sono disposti orizzontalmente a pochi centimetri l'uno dall'altro: il
vapore che risale lungo la colonna è costretto a passare
attraverso le campane di gorgogliamento disposte su ogni piatto; contemporaneamente il liquido scende
da un piatto all'altro. Se il contatto tra liquido e
vapore non è completo oppure si forma della schiuma, per cui il vapore trascina con sé una parte di
liquido nel piatto superiore, l'efficienza del processo di
distillazione diminuisce e bisogna quindi aumentare il numero di piatti presenti rispetto al numero
previsto in base a considerazioni teoriche, in fase di
progetto. L'equivalente meno costoso, ma anche molto meno efficiente, della torre di gorgogliamento
è la colonna a impaccamento, in cui il liquido scorre su
strati di anelli di terraglia o su pezzi di vetro.
L'unico svantaggio della distillazione frazionata consiste nel fatto che circa la metà del distillato
deve essere reintrodotta nella colonna e nuovamente
riscaldata, con nuovo dispendio di calore. D'altra parte però il ciclo continuo del sistema permette
di impiegare il distillato prodotto per preriscaldare la
nuova miscela, contribuendo a un notevole risparmio di energia.
Se la miscela è composta da più sostanze, è possibile spillarle a diverse altezze della colonna di frazionamento;
le torri di distillazione industriale del petrolio
hanno più di 100 piatti e 10 punti in cui è possibile estrarre le diverse frazioni. Per la separazione
di isotopi mediante distillazione vengono generalmente
impiegate torri con oltre 500 piatti.
|
5
|
|
DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE
|
Quando si riscalda una miscela di due liquidi non miscibili, le relative tensioni di vapore non subiscono
alcuna variazione e, finché i due liquidi non si
stratificano uno sull'altro, la temperatura di ebollizione della miscela rimane inferiore a quella del
componente più volatile. La composizione del vapore in
equilibrio con la miscela dipende solo dal rapporto tra le tensioni di vapore dei due liquidi a quella
determinata temperatura. In particolare, se uno dei due
liquidi è l'acqua, si realizza una distillazione in corrente di vapore, che viene usata soprattutto
per composti altobollenti che potrebbero decomporsi nelle
normali condizioni di distillazione. Un limite di questa tecnica è la richiesta che il composto non
sia solubile in acqua né reagisca con essa.
|
6
|
|
DISTILLAZIONE A PRESSIONE RIDOTTA
|
A temperatura atmosferica molti liquidi bollono a temperature estremamente alte, alle quali può aver
luogo un processo di decomposizione totale o parziale
della miscela. In questi casi, è necessario ricorrere a metodi diversi, tra i quali la distillazione
a pressione ridotta, che consente di distillare qualunque miscela
a una temperatura inferiore al suo normale punto d'ebollizione; maggiore è il vuoto che si riesce a
ottenere, minore sarà la temperatura di ebollizione. Ad
esempio, operando a 0,07 atmosfere, l'anilina può essere distillata a 100 °C. La distillazione a
pressione ridotta è efficace quanto il processo in corrente di
vapore e non presenta limiti di applicabilità, ma è decisamente più costosa; spesso quindi essa viene
usata solo quando quest'ultima tecnica non è applicabile.
La distillazione condotta con un vuoto quasi completo, chiamata distillazione molecolare, viene spesso
usata per purificare vitamine e altri prodotti instabili.
La sostanza viene posta su una piastra, in un ambiente sotto vuoto, e riscaldata: un'altra piastra raffreddata,
e collocata il più vicino possibile alla prima, funge
da condensatore. La maggior parte del composto passa da una piastra all'altra con perdite minime.
|
7
|
|
DISTILLAZIONE MOLECOLARE PER CENTRIFUGAZIONE
|
Se un'alta colonna viene riempita con una miscela di gas, chiusa ermeticamente e posta in verticale,
per effetto della forza di gravità al suo interno si verifica
una parziale separazione dei gas, in base alla densità relativa. Utilizzando una centrifuga, le forze
in grado di separare i componenti meno densi da quelli più
densi vengono amplificate migliaia di volte, e permettono di separare in modo molto efficace composti
quasi del tutto identici. Questo metodo viene ad
esempio impiegato per separare le molecole di esafluoruro d'uranio, UF6, che contengono uranio
235, da quelle che contengono uranio 238.
Il passaggio di una sostanza direttamente dallo stato solido a quello gassoso, per poi tornare nella
fase solida, senza formazione di liquido, viene detto
sublimazione. L'operazione viene condotta in modo analogo alla distillazione, ponendo attenzione al
fatto che il vapore, solidificando, non ostruisca
l'apparecchio. Non è possibile condurre sublimazioni frazionate, perciò in genere questo metodo viene
usato solo per purificare solidi volatili (come lo iodio)
da impurezze solide non volatili.
|
9
|
|
DISTILLAZIONE DISTRUTTIVA
|
Questo processo, in un'unica operazione, provoca il riscaldamento ad alte temperature di una sostanza,
ottenendone la decomposizione in diversi prodotti e
successivamente separandoli per frazionamento. Esempi importanti di distillazione distruttiva sono quella
del carbone per produrre coke, pece, metano e
ammoniaca, e quella del legno per ottenere carbone, acido acetico, acetone e metanolo. L'ultimo processo
però è stato ampiamente sostituito dai metodi
sintetici. Un processo affine alla distillazione distruttiva è il cracking del petrolio.
Microsoft ® Encarta ® Enciclopedia Plus. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
 |